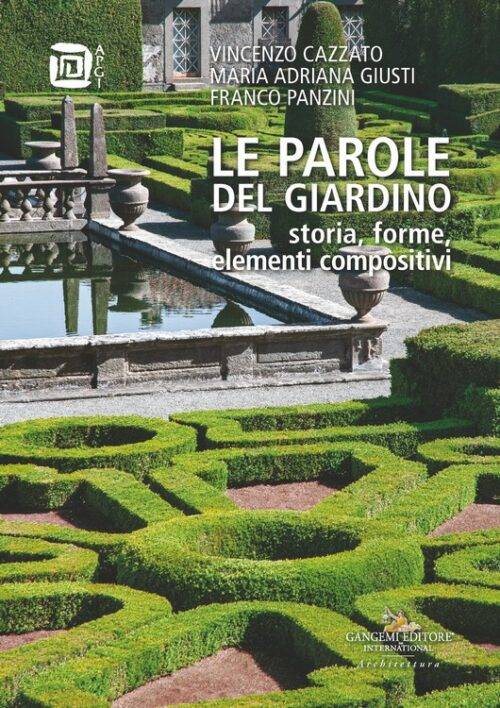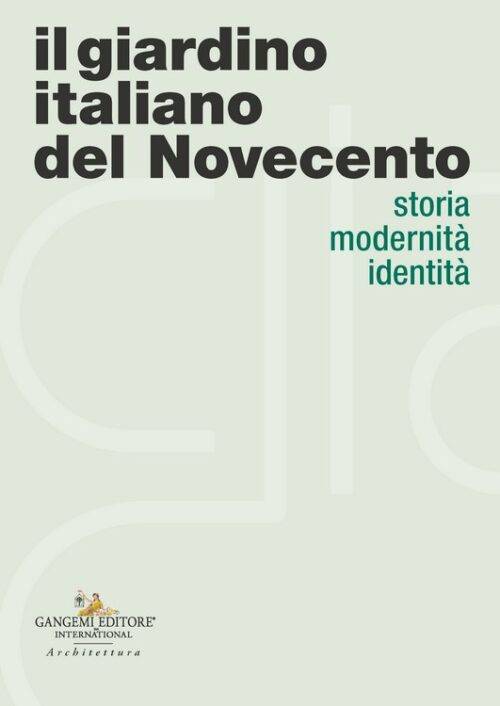35,00 €
Potrebbero interessarti anche
Gibellina. Nata dall’arte – Born from art
Una città per una società estetica - A city for an aesthetic society
Autori: Fabbri Marcello, Greco Antonella
Facing English text
Formato: 24 x 30 cm
Legatura: Filorefe
Pagine: 160
Anno edizione: 2005
ISBN: 9788849206869
EAN: 8849206860
UB. INT. : T462D T517a V41g V91g V04b
Contenuto
Premessa
L’attenta ricognizione che L. Zangara ha condotto, e le riflessioni che ne sono scaturite anche in sede di discussione della tesi ci hanno indotto a integrare e ad approfondire l’esame storico-critico di un settore specifico, che – insieme ad altri impulsi originati dal pensiero e dall’attività di Adriano Olivetti – è parte integrante della cultura italiana e dei suoi complessi caratteri specifici nella seconda metà del XX secolo; e che si riscontrano nel tempo, nel loro sviluppo, come coerenti ramificazioni di una filosofia e di una aspirazione globali d’origine. Il percorso (l’aspirazione) “verso l’estetica”, che sembra contrassegnare come uno dei motivi di fondo la concezione urbanistica italiana del “modo di pensare la città” , e la “svolta” dal Sessantotto in poi, si possono forse cogliere in questo itinerario come aspettativa o volontà sempre deluse di integrazione fra l’organizzazione tecnica e produttiva (con le “tecniche” per l’organizzazione del territorio) e i nuovi dati dei processi sociali.
La cultura del secondo dopoguerra affronta – per quanto ci riguarda – la critica alla civiltà macchinista a partire dal manifesto zeviano Verso un’architettura organica.
Dalla “riscoperta” – vera e propria “rifondazione” – della sociologia in Italia, al rifiuto della frammentazione dell’uomo nella logica unidirezionale del funzionalismo (one best way) fino all’insofferenza per l’idealismo crociano (con l’esistenzialismo e la riedizione di Kierkegaard: l’angoscia, la mossa disperatamente incompiuta di dare peso e concretezza all’istante estetico). Un vago e composito “spirito del tempo” coniuga insoddisfazioni e propositi di affrontare con nuovi paradigmi la concezione del Moderno verso una città come “fare”: una pratica sociale in cui conglobare i processi in una continua esperienza-tentativo-prova, anziché nella statica composizione di “volumi puri sotto la luce”, disposti secondo una supposta coerenza di funzioni mutuate dalla divisione del lavoro produttivo e di fabbrica. Già negli ultimi mesi di guerra – nella generale ansia di individuare i modi di una ricostruzione e di una riorganizzazione del paese radicalmente innovative – Giovanni Astengo e i suoi collaboratori avevano avviato una ricerca altrettanto “fondativa” quanto la rottura organica zeviana, con una revisione radicale delle strutture territoriali regionali, dei rapporti fra città e campagna, e fra insediamenti e organizzazioni produttive.
L’intuizione di chi già percepiva le tendenze e i problemi dello sviluppo in un’economia da ammodernare, si impegnava sui modi con cui avviare il controllo delle forme territoriali e della loro organizzazione in una visione dell’urbanistica non più concentrata sulla città, con un’analisi e una progettualità che accomunavano, in un quadro coerente, le forme urbane e i processi che si manifestavano o si prevedevano nel territorio. Ne nasceva – fra l’altro – la proposta del “Nastro produttivo padano” in cui concentrare le attività di trasformazione, con immediato riferimento alla “Città lineare” dei Disurbanisti sovietici, ma che qui interessa perché vi ritroviamo quella esigenza di una mutazione nella “figuratività” delle forme urbane, che si manifestava contemporaneamente nel neo-empirismo scandinavo o in Aalto a Rovaniemi: una flessibilità “organica” della composizione, più idonea per interventi che si adeguassero alle morfologie anche a grande scala.
Ma nella aspirazione ad un Umanesimo integrale, di cui Adriano Olivetti delineerà il programma e le coordinate per una pratica attuazione, manca ancora il luogo di coagulo concettuale – che Astengo aveva proposto in una “politica della bontà” (cioè della solidarietà) – e la drammatica critica alla “Civiltà delle macchine” individua come alternativa al rigore della tecnica (a quello che più tardi verrà designato come “algoritmo ingegneristico”) le Scienze Sociali, per una radicale revisione dell’industrialismo e delle sue forme, discipline organizzative, produttive e sociali, con una aspirazione al “Nuovo mondo” da costruire nel vuoto lasciato dalle distruzioni belliche.
Implicita e generalizzata come stato d’animo si coglie una “ideologia della libertà” indistinta ma comunemente sottintesa e intesa in termini di liberazione dell’uomo.
Ai fini di questo volume sono significativi – per quanto riguarda le arti visive – gli indizi evidenti nell’ambiente romano, anche per il ruolo di protagonista svolto da Pietro Consagra a Gibellina, e quindi in particolare in Forma 1. E perciò, ricorda Carla Accardi «ci esprimevamo con la tecnica dell’astrazione … diversa da quella milanese, che ci sembrava troppo fredda, più ispirata al design… mentre noi invece abbiamo avuto questo bisogno di passione, di immersione, di coinvolgimento, l’urgenza di fare tutto quello che ci veniva in mente, senza seguire delle strade già preindicate» (e l’Accardi sottolinea l’importanza liberatoria della presenza nel gruppo – in quegli anni – di una «artista-donna riconosciuta come essere umano a pieno diritto capace di dipingere, di creare, di avere fantasia»). E non vanno trascurate, nella cultura figurativa di quegli anni del dopoguerra, le valenze espressioniste, che vedremo riaffiorare.
Da qui l’analisi e il percorso storico-critici si possono dipanare lungo le correlazioni con le successive ricerche visive: contemporaneamente il progetto di Quaroni e Ridolfi per la Stazione Termini si inscrive nello stesso bisogno di coinvolgimento della città in una potente immagine espressiva: geniale proposta di interpretazione per Roma, carica di tutte le suggestioni e le ricchezze storiche, ma proiettata in una visione folgorante di città futura (purtroppo in seguito depotenziata nella gradevole riduzione a flessuosa pensilina per l’atrio d’ingresso).
Vi erano già state, in quegli anni drammatici, altre opere nate sotto il segno di una integrazione fra arte e architettura: in particolare il Sacrario alle Fosse Ardeatine, non solo per le eccezionali espressioni visive (Mirko, ecc.), e per tutta la concezione paesistico-architettonica, grande presenza di land-art da percorrere, vivere, sentire. Ma l’eccezionalità della finalità memoriale deviava l’esemplarità dell’opera in un lirico “una tantum”. Mentre la Stazione Termini avrebbe dovuto essere la sintesi operativa della vita urbana alla nuova scala dettata dalle prevedibili esigenze di una futura dimensione metropolitana, tramite fra la capitale ed il paese, fra l’urbano e il territorio.
È l’immagine che meglio può rappresentare visivamente il programma del saggio quaroniano L’urbanistica per l’unità della cultura2: profezia incompiuta di una città per l’uomo in cui fosse rappresentata, presente e attiva una sintesi delle forme di creatività, di ricerca, di organizzazione sociale: attuazioni di un Ordine politico delle Comunità (finalmente nel 1946, edito e leggibile) che aveva per cuore l’organizzazione della città e del territorio come concreta realizzazione fisica e operativa di una convivenza civile nella quale «Civiltà è sintesi spirituale. Se si pone mente a tutte le civiltà, alle cose che più in questo mondo si sono avvicinate all’idea di perfezione, si ritrova che in esse vi è sintesi.
Un’opera umana è tanto più vicina a questa perfezione quanto più è armonica. E non vi è armonia senza sintesi. Talché ogni attività dello spirito deve essere presente nelle opere dell’uomo.
Perché un tale stato di cose sia praticamente realizzabile in una società moderna, occorre ritrovare una sintesi ove umanità, scienza, tecnica, arte, infine gli elementi costruttivi fondamentali della società, operino coordinatamente.
Un tale stato di cose è possibile realizzando la Comunità concreta la cui complessa organizzazione è intesa a ridare alle opere dell’uomo la perduta armonia».
Il percorso che – fra proposte, illuminazioni, polemiche d’avanguardia e desideri – prende finalmente e fisicamente corpo a Gibellina sub specie civitatis, si era quindi avviato nell’immediato dopoguerra come reazione alla città macchinista, alla sua ideologia e al suo impianto “funzionalisti”, e agli schemi paradigmatici delle tipologie architettoniche e urbane maturati con le elaborazioni, il dibattito, le esperienze – e anche le affascinanti realizzazioni – del Razionalismo architettonico.
Fra i temi portanti che confluirono e si integrarono in quella esperienza siciliana possiamo seguire i filoni principali a compimento della “revisione del Moderno”.
Abbiamo già accennato alla volontà di integrazione delle Scienze Sociali nell’urbanistica. Il predominio fra i contributi “revisionisti” – dell’influenza delle Scienze Sociali, fino ad una osmosi con la pianificazione urbana e territoriale, derivava direttamente dalla tradizione ottocentesca fondativa dell’urbanistica moderna, nata dall’impulso di lenire i mali dell’urbanesimo prodotto dalla rivoluzione industriale; nell’immediato, dalla suggestione dello studio su Matera e dai successivi interventi e realizzazioni, che si configuravano come il più cospicuo esempio di rinnovamento dell’architettura e dell’urbanistica, a partire da una piattaforma di indagini e studi storico-sociali e in un ambiente non solo di grandissima suggestione (sottolineata dalla lettura che ne aveva fatto Carlo Levi nel Cristo si è fermato a Eboli), ma che rappresentava la più eclatante e dimostrativa sintesi dei problemi che avrebbe dovuto affrontare il passaggio verso la “modernità” non solo italiana.
Per cogliere in una data simbolica il momento e il luogo del passaggio fra due poetiche e corrispondenti ideologie e metodologie nettamente divise e contrapposte nella comune opinione architettonica e urbanistica, potremmo segnare il Congresso CIAM di Bergamo (1949) come cesura ufficiale e pubblica e apertura evidente di quella crisi “revisionista” della pratica progettuale per la città e l’ambiente totale di vita dell’uomo – di cui Bruno Zevi nel Messaggio indirizzato ai congressisti approfondiva l’analisi e tracciava i possibili esiti innovativi.
Per Zevi quel Messaggio era il prodotto già lungamente meditato di un itinerario di cui sono esposte con chiarezza origini e motivazioni nel saggio Benedetto Croce e la riforma della storia architettonica3 (“Metron” 1952, n. 47).
Con quell’omaggio al Maestro, che dava solida fondazione storica e filosofica alla metodologia del Saper vedere (1948) e alla Storia (1950), per l’architettura contemporanea si apre un quadro di lettura coerente con la ricerca estetica, e non come eccezione, esercizio “a parte” dotato di proprie regole e specifici protocolli.
Gli strumenti di lettura possono essere diversi, così come le particolarità disciplinari; e si può considerare opportuno «comporre libri teorici sulle singole arti, non perché in ciascuna siano da ragionare particolari concetti estetici, ma al contrario per far valere in ciascuna i concetti medesimi dell’Estetica, attraverso la diversità delle terminologie, delle abitudini mentali, della varia importanza e urgenza, e del materiale esemplificativo»4. L’Architettura viene riammessa nella filosofica famiglia dell’Estetica, non più dimidiata a tecnica empirica alla quale l’illuminazione della Grazia non si sapeva da dove arrivasse se non dall’ubbidienza a regole e modelli (gli architetti confinati fra i “meccanici”): il ritorno storicistico alla dignità dell’homo faber, da Morris in poi, legittimava anche per gli architetti la rivendicazione di un’ideologia della libertà, umanizzatrice ed emancipatrice.
Rientrati nella famiglia delle Arti, i figli prodighi non compresero subito quali grandi possibilità si schiudessero in quel fervido ambiente familiare: facevano eccezione alcuni pochi che però avevano sempre praticato l’eresia e perciò guardati con sospetto e condiscendenza (Carlo Mollino, Hans Scharoun, Giovanni Michelucci, Luigi Moretti – l’elenco potrebbe continuare: con Maurizio Sacripanti ad esempio…); sono piuttosto gli artisti ad avviarsi per esplorare nuovi spazi. Dal gruppo COBRA al “Cercle et Carré,” a Constant l’urbano diventa non solo un luogo di ispirazione, ma una volontà creativa di configurazioni e invenzioni spaziali: una genealogia che maturerà nelle proposte di Consagra, provocando, nella svolta fine anni ‘60 una contestazione nei riguardi dell’Uomo a una dimensione, nella quale si integrano le sperimentalità di varia provenienza – da Gallizio alla New Babylon al teatro, alla musica (Paesaggio metropolitano) 5.
Ma va qui ricordata – per inciso – l’influenza fondamentale delle nuove ricerche spaziali che tendevano a sovvertire il rigore figurativo “razionalista”: in particolare la forza fantastica dell’architettura brasiliana e sudamericana (dal quartiere Pedregulho, Rio de Janeiro 1947-50, alle prime opere di Niemeyer, alla fantasia ambientale di Burle Marx).
La pratica estetico-comunicativa come luogo sempre frustrato di integrazione di tutte le aspirazioni per un Umanesimo integrale, ma condizione sempre sperimentale verso … Potremmo citare le ricerche di Ludovico Quaroni, per captare spazi con una flessibilità delle forme urbane, che approderanno, ancora senza realizzazione concreta, al colloquio visionario fra gli emicicli delle Barene e il profilo evanescente di Venezia, attraverso la laguna e i suoi riflessi (anche qui profezia di una land art performativa giocata sull’acqua).
Nel clima postbellico di tensione culturale e politica, l’integrazione fra urbanistica/architettura e le scienze sociali appariva soprattutto come esplorazione di nuove vie per far collimare le forme urbane e territoriali con le proposte di radicale rinnovamento delle società e del modo di vivere; e quindi con immagini architettoniche che traessero origine da “archetipi” individuabili in primigeni linguaggi “spontanei”. L’influenza di una “poetica nazional-popolare” in tutta la cultura italiana è già stata dibattuta a sufficienza: qui segnaliamo soltanto, come dirimente per noi e radicalmente creativa, la lettura zeviana dei Sassi di Matera, interpretati come concreta città neoplastica secondo la profezia di Mondrian.
Ma procedendo ben oltre gli impacci populisti, la ricerca di integrazione ai fini di rinnovamento disciplinare (e – in coerenza – di rinnovamento dell’assetto fisico e dell’immagine italiani) si attuò con piani originali degli anni ‘50/’60, e con i progetti di sviluppo comunitario, a volte collegati fra loro6.
L’orizzonte in cui ci si muoveva era quello di un progetto globale di trasformazione che, sulla base di analisi rigorose, approdasse ad un processo di trasformazione condotto collettivamente e controllato dalla Comunità. (Evidente in questo proposito – in particolare nello sforzo di integrare le competenze disciplinari con la gestione politica – tutta la forza innovativa delle proposte contenute nell’Ordine politico delle Comunità).
Si può concludere l’itinerario dei progetti di sviluppo comunitario con il Convegno di Sorrento (1968) con una presenza significativa delle esperienze siciliane, fra le quali, da tempo, si era distinto per singolarità di impegno solidaristico e organizzativo il Centro Studi e Iniziative di Partinico, fondato e guidato da Danilo Dolci; che va inscritto nella “singolarità siciliana” di quegli anni: letteraria (Sciascia, il Gattopardo, Horcynus Orca ecc.) o cinematografica; una situazione poetica, a cui faceva riscontro, nei nostri settori, la presenza di personaggi altrettanto genialmente “profetici”: Carlo Doglio, Leonardo Urbani.
Questa deviazione permette di introdurre un accenno ad un climax che in quegli anni accoglieva, in un quadro culturale molto complesso, non solo suggestioni che poi sarebbero state definite “terzomondiste”, ma anche solide direzioni di ricerca e proposta, quali quelle presenti nella programmazione nazionale che sollecitavano un riequilibrio negli assetti generali dei Paese, con una proiezione coordinata sia verso l’Europa che verso il Mediterraneo, con l’apertura di nuove configurazioni politiche nate dalla decolonizzazione. Riassetto che comprendeva anche uno sviluppo delle zone interne e una decongestione delle aree costiere: echi ben percepibili nelle linee dei Piano di sviluppo che inquadrò la strategia territoriale della ricostruzione siciliana.
Riteniamo (e fra parentesi) che se quelle speranze sono andate deluse, non sia stata soltanto la Forza del Destino, ma anche perché l’Italia – parte integrante di un’Europa chiusa su se stessa – non ha potuto esercitare le influenze che politici non solo “illuminati” (La Pira), ma anche abili e non certo “sprovveduti” (come lo stesso Aldo Moro) avevano tentato. Sarebbe un’altra storia, se non si inserisse: a) da un lato in una concezione dì “nuovo meridionalismo” che comprendeva le elaborazioni di rinnovamento del dopoguerra, e si distingueva per un rifiuto dei grandi “poli”, optando per la creazione di un tessuto di fattori di sviluppo locali interrelati (e a prevalere fu invece la scelta “gigantista” che paghiamo oggi); b) in una concezione politico/istituzionale decentrata e federalista; c) quindi dall’altro lato in una ovvia ostilità istintiva per ogni progetto fortemente innovativo, nel Sud e particolarmente in Sicilia, che non fosse subalterno rispetto a quelli che non si chiamavano ancora “poteri forti” soprattutto concentrati nei luoghi di intervento economico pubblico (leggi IRI) e in particolare nel rifiuto della “Grande Illusione” di piegare l’intervento pubblico alle esigenze sociali. Divagazioni di non poco conto, senza le quali non è possibile spiegare l’isolamento in cui ci si trovò ad operare, dopo i primi mesi di idillio.
Mentre, in coerenza, anche la storia architettonica e urbanistica aveva imboccato le vie dei “grandi disegni”, ritornando cioè ai Piani Obus genialmente (o meno) prefabbricati: i grandi contenitori, Cumbernauld, i “cucchiai” di Lubycz-Nicz, Kenzo Tange ecc. come modelli suggestivi di “poesia a grande scala”, campati ovunque, in aria o sulla Baia di Tokyo, poi irrisi dagli Archigram (che supponevano le stesse megastrutture dotate di gambe e peripatetiche …), o da Superstudio, nella dissacrazione del ‘68, e finalmente realizzati nella parodia petrolchimica del Beaubourg, Colosseo manierista dell’era paleoindustriale; e sempre unificando il vocabolo bâtiment con la figura del “bastimento”, Titanic o gloriosa fabbrica fordista.
Parole chiave
Condividi su