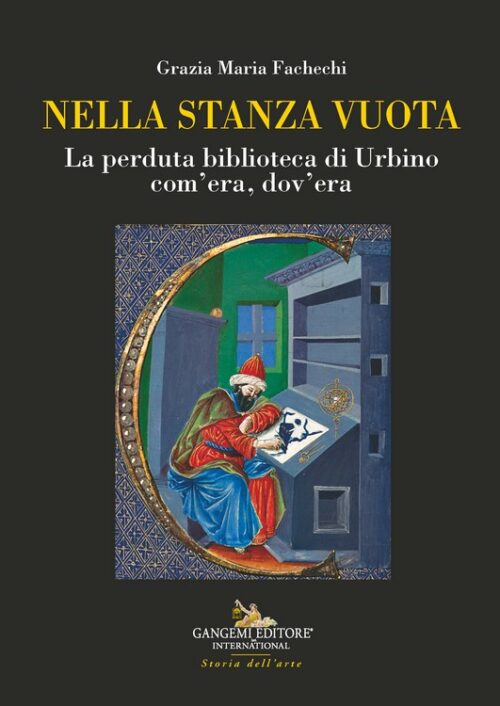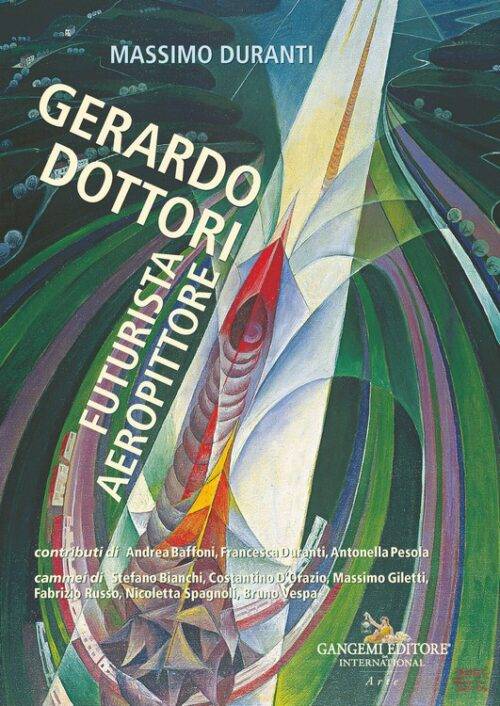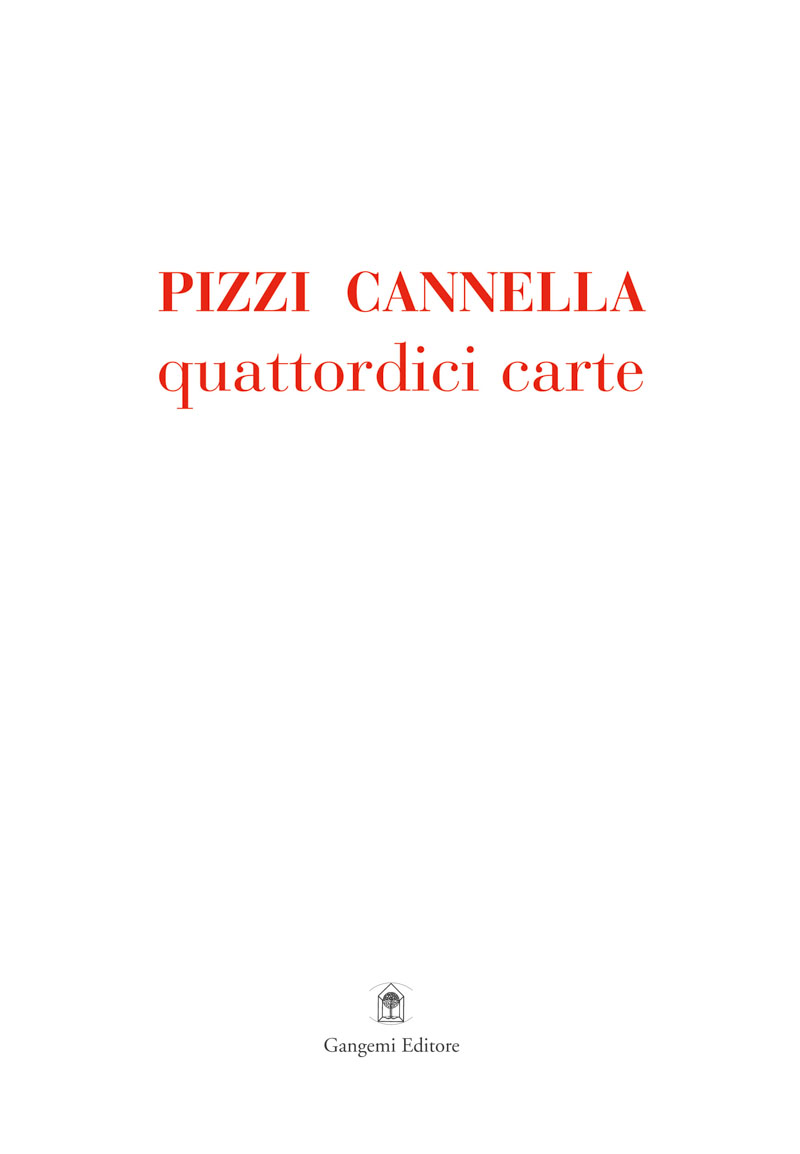
15,00 €
Potrebbero interessarti anche
Pizzi Cannella. Quattordici Carte
Autori: Presilla Lucia
Formato: 17 x 24 cm
Legatura: Filorefe
Pagine: 48
Anno edizione:
ISBN: 9788849207910
EAN: 8849207913
UB. INT. : T511C V16a
Contenuto
My little vicious circle
Segni di bicchiere su un bancone di legno: una sequenza astratta di circoli lucidi che si intersecano sovrapponendosi l’uno all’altro. Il cerchio è la “figura geometrica perfetta”, chiosa Ray Milland nel film The Lost Weekend (1945), “non ha fine, non ha principio”. Come il suo assillo, che egli fissa dinanzi a sé nel correlativo oggettivo del bicchiere divenuto lugubre memento mori. Se prega il barista di non asciugare il tavolo, è per il timore di veder sparire l’unico indizio della propria esistenza, della propria tremenda ossessione. Frattanto, in un diverso emisfero creativo, gli anelli rossi si infittiscono sul piano del foglio, addivenendo a una macchia compatta e densa come l’ombra cinese posta di fianco, quest’ultima caliginosa, impenetrabile, slabbrata appena nei profili. Un cerchio che può accelerare anche in un Giro giro girotondo (2003), analogo all’avviticchiarsi in un ulteriore disegno dei chicchi perlacei sul dorso dell’anfora.
I ritornanti, i trasversali accompagnatori di una vita, gli oggetti inseparabili, occasioni di una riflessione che trova compiutezza e appagamento nel ripercorrere gli stessi sentieri, nel perlustrare le stesse strade. Per Pizzi Cannella il “piccolo circolo vizioso” corrisponde agli appunti mentali consegnati alle carte – “direi che è una specie di vizio”, confessa a proposito dei taccuini di viaggio, e latamente in riguardo alla diuturna necessità di creare immagini, “uno spazio circolare, un ritorno sul luogo del delitto”. Figure che si presentano nei disegni liberate dalle condizioni e dai limiti spazio-temporali, non però dalle sgocciolature della memoria. Una memoria introspettiva, aggrappata a una materialità corposa, in ragione di uno scandagliare per vie intuitive – il senso, la tattilità – cui devono apparire certo superflui i trascendentalismi ispirati o le inclinazioni raziocinanti. Come una scrittura stilata a commento degli accadimenti e della fenomenologia del vissuto, il diario visivo affidato al supporto delicato, leggero e arrendevole della carta si situa nel territorio dell’inconfessabile, interloquendo con un unico ascoltatore, sempre il medesimo, l’autore.
L’attività del disegno invero non ha molto a che spartire con il lavoro su tela. Eccezion fatta per studi preparatori e bozzetti, esercizi di calcolo o strumenti di verifica espressiva che preludono a una successiva fase di elaborazione, preminente nell’opera disegnata si configura la tracciatura rapida, la notazione abbreviante conchiusa nel volo lirico dell’intuizione. Anche in Pizzi Cannella carte e tele procedono su binari distinti e distinguibili, per una diversa relazione del contenuto figurale con l’estensione bidimensionale dell’opera. Cambia pure il punto di partenza, che nelle tele è sempre un pieno. Nei disegni invece le sagome vibrano nel vuoto, anziché posarsi su un fondo costruito e puntellato architettonicamente, o trovare definizione rapportandosi a una superficie, misurandosi nella profondità, stabilizzando la propria presenza all’interno di una composizione data. Le figurazioni appaiono come epifanie nel nulla mosso e accidentato, nel rumoreggiante vano sgombro del foglio. Il brusio è dato dalle macchie e dalle tracce di pigmento, per solito color pece. Il procedere è convulso, assicurato nella prontezza dell’annotazione dalla mano svelta, tempestiva, il cui moto è attivato direttamente dall’immaginazione. Non ci sono interruzioni, ripensamenti, non si procede per via di levare, come avviene invece nei quadri, ove “eliminando tutto il superfluo si raggiunge lo stato nel quale non si può eliminare più niente” (Pizzi Cannella). L’immagine si offre precisa e risolutiva, a patto di non lasciarsi fuorviare dalle sbavature, dai sedimenti di materia, dagli strati di carta sovrapposti, o dalle velature liquide che impregnano il supporto in modo irregolare. Codeste circostanze collaterali, come si presentano all’occhio, non hanno il potere di intaccare il nucleo vivido della forma – sintetico sempre nella scrittura dell’artista, richiamato per mezzo di accenni e presagi – che par quasi impresso a fuoco, rivelando una sorta di endocarpo incorruttibile.
Gli anelli neri disposti a flotta, direzionati come una costellazione paiono curarsi solo di conferire nettezza e leggibilità alle coordinate di riferimento. Il foglio diviene mappa, come la carta geografica immaginaria de La isla (2004), un’ipotesi di viaggio nel pullulare di traiettorie, scambi, tracciati. Su tutto – fili di perle e ombre cinesi, maschere, piccole lucertole, musiche per camere d’artista e preziosi pendenti – aleggia un color fosco, un odore di notte che investe i fogli di carta a mano, aprendosi talora ad accensioni subitanee: lampi di verde primaverile, striature sanguigne, scritte colorate come immagini, parole che sono linee e geometrie. Aggiunte in quella grafia incerta e vacillante che naviga al ritmo stesso delle visioni, queste ultime si combinano nell’opera agli inserti materici alleggerendone il peso specifico, e insieme prolungandone l’eco.
E le vesti?
“‘La carne e il sangue non ereditano il Regno di Dio’, ma il vestito eredita. Il vestito è parte del corpo. Nella vita comune è una estensione esteriore del corpo, analoga al vello delle bestie e al piumaggio degli uccelli (…) compenetrato ai più sottili strati dell’organizzazione corporea il vestito in parte entra nell’organismo” (P. Florenskij). Se la veste può essere dunque considerata una manifestazione del corpo, nel senso che ne indica la struttura, e ammessa la sua facoltà di annunciare l’essenza metafisica dell’uomo, allora quegli abiti laconici definiti da pochi tratti stringati che Pizzi Cannella adotta a codice identificativo del proprio operare alludono a presenze concrete, anzi ne lasciano l’impronta più preziosa, un involucro le cui radici affondano lontano, in un tempo già abitato. In Bella cuore mio (2003) oltre al sillabato indumento femminile si riaffaccia il cerchio, in atto di addentarne il profilo. Si dissimula e mimetizza l’idea di un bersaglio, un tiro a segno occhiato e numerato che altrove un grembo calamita presso di sé, tra fianchi arcuati stavolta di un azzurro snebbiato e pastoso.
L’Autoritratto (2003) è una pila di occhi in bilico in margine al campo visivo, occhi che incorniciano un ventaglio tenero e trasparente, e fissano lo spettatore senza remora alcuna. Ora, sì, questi viene interpellato in un dialogo serrato ed esclusivo, mentre il resto può rimanere in disparte. Si svelano allora in certa misura le regole del gioco, prima fra tutte che il giocare presuppone anche sempre, da parte dell’attore, un mettersi in gioco. No end, no beginning. Nel reiterato materializzarsi di pochi simboli, frontali e solitari – hanno l’aria di galleggiare in uno spazio di ricordi e affetti individuali, piuttosto che introdursi in una messinscena apparecchiata a uso e consumo del riguardante –, le carte di Pizzi Cannella raccontano di una familiarità disinvolta guadagnata in lunghe e appartate frequentazioni. L’alchimista che dispone a piacimento di tali vocaboli, quasi vecchi amici e compagni di strada, se ne serve per perlustrare un territorio di frontiera tra coscienza e sogno, foglio per foglio, giorno dopo giorno.
Lucia Presilla
Parole chiave
Condividi su